Sonavan le quiete stanze by Pier Vincenzo Mengaldo
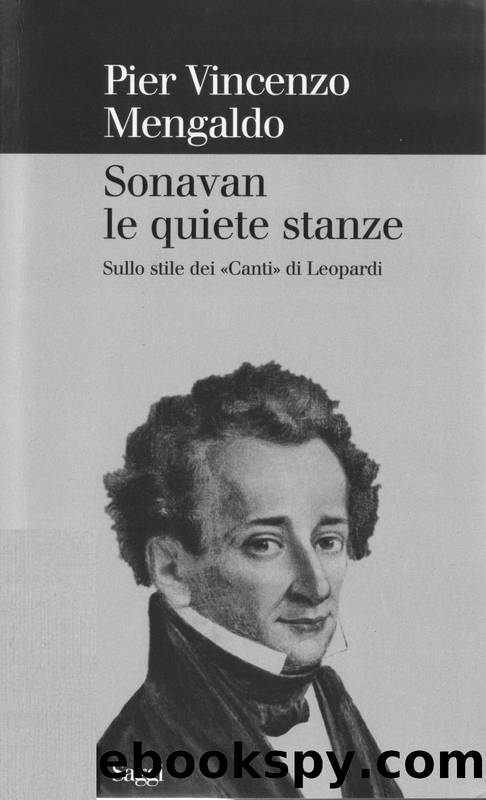
autore:Pier Vincenzo Mengaldo
La lingua: eng
Format: mobi
pubblicato: 2012-03-14T12:28:36+00:00
IV â LEOPARDI NON Ã UN POETA METAFORICO
Questa è la tesi da dimostrare65. Cominciando dalle Canzoni, la cui alta eloquenza farebbe a rigore supporre un tasso figurale più alto. E invece l'unica similitudine vera e propria â e peraltro già omerica â ha luogo nella più antica All'Italia 103 ss.: «Come lion di tori entro una mandra... Tal fra le Perse torme infuriava...». Sempre nella prima canzone, 21, la metafora tradizionale della fonte per gli occhi in lacrime è inserita in una pseudo-similitudine iperbolica: «Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive...», e quella di Sopra il monumento di Dante 79 ha un basso tenore figurale: «Saldi men che cera e men che arena», mentre un'altra comparazione è sfumata, 94: «Parea che...». Due sole le analogie, una più razionalizzata, Sopra il monumento 145: «Ed era letto agli egri corpi il gelo», l'altra invece di potente antropomorfismo, Patriarchi63: «...l'occiduo Sol naufrago uscendo» (in un manoscritto napoletano Leopardi scioglie in una comparazione: «cioè come un naufrago esce dalle acque»); non si può infine considerare analogia, ma affermazione di un'equivalenza simbolica, All'Italia 125: «La vostra tomba è un'ara». E anche qui è tutto. Nell'insieme, colpisce la concentrazione nelle due prime canzoni del '18.
Naturalmente il numero delle metafore è molto più alto. Ma la quantità di gran lunga maggiore si distribuisce entro queste due categorie. La prima: metafore consunte e quasi lessicalizzate, potremmo dire catacresi poetiche: «pungere» Monumento 16; «favilla» ibidem 51, Vincitore 29 ecc.; «fiamma» in vari sensi, Monumento 102, Sorella Paolina 40 ecc.; «grido» 'richiamo', 'fama' Mai 20, Paolina 69, Patriarchi 88; «nido» Paolina 1 ecc.; «polve» della vita ibidem 5; «famiglia» 'progenie' ibidem 10; «seno» Vincitore 26 (instaurato con sordina classica sul più espressivo «gorghi»), Ultimo canto 33; «albergo» Primavera 23-24, Patriarchi 46; il petrarchesco «velo» 'corpo' Ultimo canto 55 ecc.
Alla seconda categoria appartengono metafore in sé più interessanti ma che, in quanto tali o per il nesso in cui sono inserite, rimandano a precedenti o «fonti» precisi, e dunque all'orecchio del coltissimo poeta sono anch'esse in qualche modo lessicalizzate, indici di un patrimonio comune: un patrimonio che Leopardi riattiva anzitutto per far vivere paradossalmente nelle forme dell'antico quella «lirica» che egli riteneva incompatibile con la modernità . Esempi: «lacci» Monumento 3 (Petrarca...); «vedova» ibidem 9 (Monti), e con «sola» in chiusa 200 (Dante); «turbo» ibidem 54 (Alfieri); «vorago» ibidem 109 (Monti); «attuffare» Mai 79 (Ariosto e Tasso); «sera» 'il declinare' Sorella Paolina 20; «tenzone» dei venti ibidem 50; «sfavilla» (d'ira) ibidem 97 (Tasso e Marino); «caterva» Bruto 112 (Manzoni); «atra / Face del ver» Primavera 13 (Virgilio); «ira de' venti» Patriarchi 45 (Tasso); «consorti ricetti» ibidem 50 (è lo stesso Leopardi a citare in una nota i «consortia tecta» virgiliani); «suggere» ibidem 106 (è ancora una nota di Leopardi a richiamare, per l'accezione, Virgilio), ecc. Un'altra, incisiva, metafora, la «nebbia di tedio» di Mai ha un riscontro interno nello Zibaldone (del resto in Monti si trova «nebbia degli anni»).
Sono dunque più personali e intense, con pochissime altre, queste metafore: «tedio che n'affoga» Mai 72; «secol di fango» ibidem 179; «piena degli anni» (corr.
scaricare
Questo sito non memorizza alcun file sul suo server. Abbiamo solo indice e link contenuto fornito da altri siti. Contatta i fornitori di contenuti per rimuovere eventuali contenuti di copyright e inviaci un'email. Cancelleremo immediatamente i collegamenti o il contenuto pertinenti.
Donne e dee nel Mediterraneo antico by Paola Angeli Bernardini;(374)
Qualche mese della mia vita by Michel Houellebecq(349)
Caccia allo Strega by Gianluigi Simonetti(345)
Resisti, cuore by Alessandro D'Avenia(329)
Nei sobborghi di un segreto by Marisa Bulgheroni(307)
L'occhio del mondo by Marcello Sabbatino;(296)
In cerca di Amleto by Piero Boitani;(293)
Gli ultimi viaggiatori by Brilli Attilio(289)
Il libro dei racconti perduti. Seconda Parte by J.R.R. Tolkien(284)
Mitologia Norrena by Historia Magistra(283)
Boccaccio indiscreto. Il mito di Fiammetta by Marco Santagata(281)
Amore Tormentato by Tiziana Cazziero(275)
Enigma Galattico by Walter Ernsting(273)
Hofmannsthal e il suo tempo by Hermann Broch;(262)
Gli occhi del vuoto (Fanucci Editore) (Italian Edition) by Adrian Tchaikovsky(261)
Cento by Marco Antonio Bazzocchi;(258)
La fusione nucleare. Mito o realtà ? by Simone Baroni(257)
Pietà e terrore by Giulio Guidorizzi(248)
Sogni Antichi E Moderni by Pietro Citati(244)
